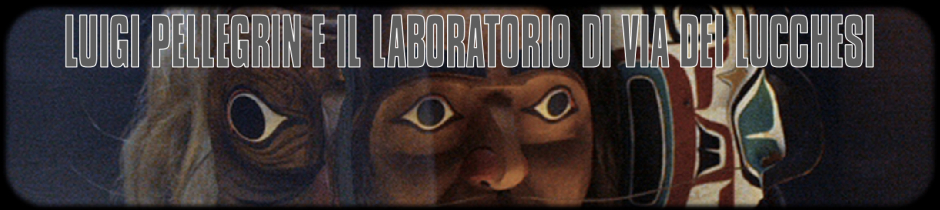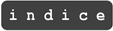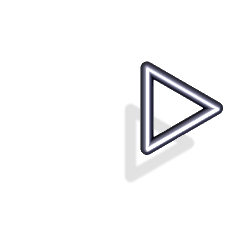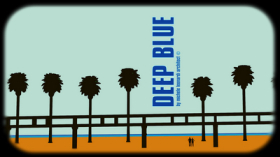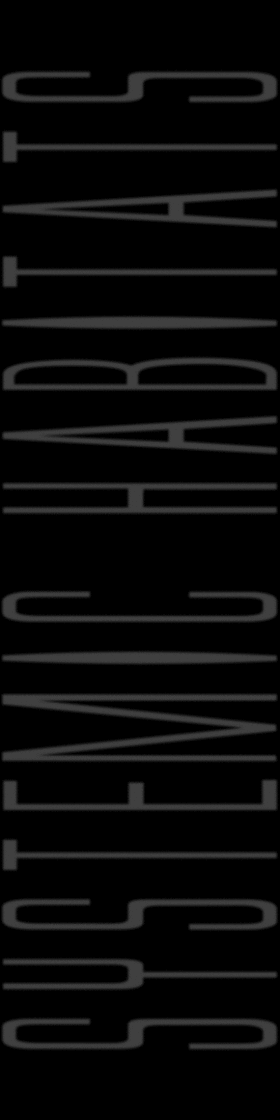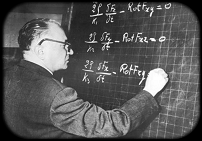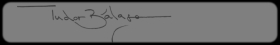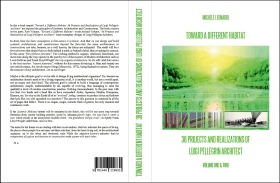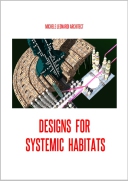Capitolo 7 - Contenuti extra
L'ARCHITETTURA SISTEMICA
Saggio di Pasquale Cascella - Parte Terza © - aggiornato al 31 luglio 2023-in fieri
EVOLUZIONE DEI SISTEMI COSTRUTTIVI IN ITALIA
NEGLI ANNI ‘70
Nel dopoguerra si sviluppò una ricerca industriale per rispondere alle crescenti esigenze della stessa industrializzazione. Servivano grandi coperture ma poco costose. Si implementò quindi una ricerca volta ad ottimizzare le prestazioni con risparmio di materiale, cui seguì la realizzazione di capannoni con copertura a botte, a shed. Molte industrie misero a punto sistemi per migliorare le luci ed i pesi dei solai. A seguire iniziò la produzione di pilastri, travi e pannelli di tamponamento esterno prefabbricati in c.a. (le strutture in ferro, in Italia, all’epoca avevano costi proibitivi). I nuovi sistemi riducevano la manodopera in cantiere, affrancavano dai ritardi condizionati dalle intemperie e miglioravano decisamente la sicurezza degli operai. Successivamente, con l’avvento del precompresso ed un crescente miglioramento delle prestazioni delle autogru, nelle coperture dei capannoni industriali si diffuse l’impiego di tegoli (o copponi) in grado di coprire notevoli luci a costi contenuti. Miracoli degli industriali-artigiani italiani, capaci di inventare sistemi economici anche senza avere grandi commesse.
In questo contesto Pellegrin intravide la possibilità di migliorare e potenziare questo nuovo modo di costruire per impiegarlo anche nell’edilizia civile. Tutte le conoscenze ed esperienze accumulate negli anni 50-60 e la consuetudine con il cantiere - dove a 5 anni già viveva con la famiglia, giunta a Roma con altri edili e carpentieri specializzati friulani per la realizzazione del Buon Pastore di Armando Brasini - trovarono negli appalti-concorso, banditi dal Centro Studi Edilizia Sperimentale del Ministero della Pubblica Istruzione, la possibilità di elaborazione progettuale e sperimentazione al vero di nuovi sistemi di prefabbricazione a secco. Banditi la calce e l’intonaco. Sistemi costruttivi nuovi per una nuova “architettura sistemica”; nuova metodologia di progettazione per realizzare singoli edifici (le scuole) subito, e la nuova città domani, attraverso un nuovo approccio ‘tecnologico’ alla progettazione. Potenziare il mestiere del costruire era il passaggio necessario per poter costruire, “alla grande scala”, l’Habitat del futuro. Una nuova città da sviluppare ristrutturando quelle che si andavano espandendo a macchia d’olio in tutto il mondo. Questo l’immenso compito progettuale che Luigi Pellegrin si prefisse e si impose, per tutti gli anni 70-80-90, fino a quando poté, l’anno 2001.
Negli anni ’70 a noi studenti diceva: “mentre imparate a fare le ‘aste’ (gli esercizi pre-scrittura) dovete pensare ed allenarvi a pensare in grande, alla ‘grande scala”. Ritengo il progetto-chiave dell’evoluzione di Pellegrin - da wrightiano a maestro di architettura sistemica proiettata al futuro – quello per il concorso dell’università di Barcellona. In questo caso, la possibilità di un ambito di intervento di maggiore dimensione, rispetto alle scuole, gli dette la possibilità di fissare sui disegni il passaggio dall’edilizia estensiva e divoratrice di terra (e di relazioni tra gli abitanti) ai sistemi industrializzati per “sollevare le costruzioni da terra”. Certo c’erano già stati Le Corbusier ed altri, ma il percorso progettuale e costruttivo che indicò fu altro. Non basta il ‘piano pilotis’, occorre immaginare uno spazio abitato da organismi tra loro relazionati. Noi studenti dovevamo lavorare a questo. I più tendevano a rielaborare un suo progetto, io no. Avevo esuberanti intenti progettuali senza ancora la maturità per poterli ‘chiudere’. Così ad ogni revisione, invece di presentare l’avanzamento del progetto, ne portavo uno nuovo, o meglio ‘un nuovo intento progettuale’. Lasciava che seguissi la mia strada. Nel frattempo, durante le attese, mi accostavo al tavolo dell’allora suo, impagabile, braccio destro Carlo Cesana (con il quale in seguito divisi lo studio per sette anni) e osservavo lo svolgimento del progetto secondo la metodologia della prefabbricazione.
Il frutto realizzato dell’architettura sistemica di Pellegrin è stato essenzialmente nei sistemi costruttivi in prefabbricato di scuole. I tanti risultati tangibili, sparsi in tutta Italia, rappresentano un vero cambiamento tipologico, raggiunto non solo dal punto di vista costruttivo, ma anche nella composizione degli spazi e nelle relazioni tra le diverse attività dell’organismo scolastico. Tutto ciò non fu accolto, come avrebbe detto lui. Nel susseguirsi delle mode (il Post-Modern, il decostruttivismo, il ‘minimalismo’…) - fu snobbato, non trovò cittadinanza.
Si aggiunse il fattore ‘insegnamento di massa’, che determinò un abbassamento del livello culturale dell’insegnamento. Per studenti e docenti era meglio buttarsi su architetture meno complesse, che richiedessero minori cognizioni tecniche, minore cultura generale, minore capacità di ‘vedere nello spazio’ come diceva Pellegrin. Poi, dato che ogni epoca deve avere i suoi “totem”, si fecero largo alcuni con buone capacità artistiche, in alcuni casi anche di notevoli conoscenze tecnologiche, sempre dotati di capacità manageriali, e, dopo un’abominevole riscrittura dell’architettura moderna, si formò lo Star System. La comunicazione globalizzata portò ai grandi studi con incarichi in tutto il mondo, vere e proprie aziende che devono fatturare, con inevitabile riduzione dell’interesse per la ricerca progettuale che l’architetto dovrebbe avere verso la soluzione dei problemi del suo tempo. Mi disse un giorno D’Olivo: “Anche un maestro come Kenzo Tange, una volta che diventa la sigla di una company, non è più lo stesso”.
Pur in presenza di un grande avanzamento tecnologico, negli anni seguenti, con poche eccezioni, gli architetti si fermarono all’edificio piantato a terra, scarsamente integrato nel contesto urbanistico, dove l’originalità risiede essenzialmente nella “facciata”, come nell’ottocento, ma senza quelle regole urbanistiche che, in quell’epoca, almeno ne determinavano un contesto armonico. Facciate high tech, colorate, cangianti. Alla fine raramente oltre il parallelepipedo piantato a terra, al di là di qualche scasso o apertura sul volume. Il mondo spalancato da Buckminster Fuller, le ricerche di Pellegrin, Soleri ed altri, restarono misconosciuti ai più; i loro progetti realizzati obliati; quelli non realizzati tacciati di essere irrealizzabili.
Al punto di crescita demografica in cui siamo arrivati sul pianeta, al punto di compromissione della biosfera, con tutto quello che ne consegue, possiamo continuare a costruire megalopoli estensive, dove tende ad insediarsi il 90% della popolazione umana? In quale misura possiamo contribuire a modificare il crescere della città insostenibile utilizzando l’alta tecnologia solo per i progetti ‘di rappresentanza’, del grande commercio o degli uffici finanziari?
COMPONENTI EDILIZI INDUSTRIALIZZATI
Pellegrin nel progettare sistemi prefabbricati per le scuole aveva messo a punto una metodologia progettuale per concepire i componenti della costruzione. Travi, pilastri, solai, pannelli di tamponamento, tutto montato a secco, senza operazioni “umide”. Già negli anni ’80 il prefabbricato in c.a. era oramai assemblato meccanicamente, senza getti integrativi e di unione in opera. Dai tempi di Nervi, il c.a. realizzato in stabilimento aveva raggiunto livelli di resistenza talmente elevati da rendere impensabile una trave per metà realizzata con c.a. super e l’altra metà, quella gettata in opera, con c.a. mediocre. Dal punto di vista architettonico le scuole realizzate di Pellegrin dimostravano che l’industrializzazione, in mano sapienti, non comportava più una diminuzione della qualità, tutt’altro, consentiva invece migliore qualità sia nella composizione spaziale che nei materiali impiegati.
Personalmente, dati gli studi fatti alla scuola di Via dei Lucchesi, cercai e ottenni incarichi di progettazione e direzione lavori di scuole. Furono per me l’unico campo dove potei applicare l’architettura sistemica quanto meno al primo stadio. Riuscii in due casi a realizzare anche veri e propri sistemi di prefabbricazione in c.a. da me progettati e realizzati con l’apporto dell’insuperabile esperienza di due geometri formatisi nel dopoguerra alla scuola della Gianese di Milano. Il caso volle che li conoscessi presentati da due diverse imprese generali che si erano aggiudicate l’appalto di due mie diverse scuole. In un caso, addirittura, la scuola andava realizzata in due distinti lotti, per cui fu realizzato un vero e proprio sistema costruttivo prefabbricato per mezza scuola! La cosa più importante che ho fatto nella mia carriera edilizia è stata proprio questa: dimostrare che l’ingegno è abbinato alla capacità di noi italiani di saper essere “sarti” costruttori (stavo per dire santi…), anche quando l’economia direbbe che è impensabile realizzare un nuovo sistema - composto da pilastri con piccole mensole, travi, travi canale portanti, solai e pannelli di tamponatura esterna a superficie finita con graniglia di pietra gialla - per mezza scuola. Fu possibile grazie al compianto amico fraterno Mario Peruzzotti da Gallarate e grazie all’amico Luciano Redaelli da Milano, trapiantato a Caserta dove ha sede la sua azienda. Grazie Mario, grazie Luciano, che vi siete voluti cimentare con me nella realizzazione di queste piccole, quanto emblematiche dimostrazioni delle possibilità dell’architettura sistemica, seppur alla piccola scala, a quella in cui si fanno le aste (come un tempo nella pre-scrittura). Maestri del calcestruzzo prefabbricato e del disegno meccanico (a mano, i computer all’epoca erano ancora lontani), voi che avete reso possibile la realizzazione di queste scuole, le quali gli studenti di ingegneria strutturale di Napoli, in visita allo stabilimento, non mancano di visionare attraverso i disegni e le foto appesi negli uffici aziendali. Abbiamo dimostrato la possibilità anche economica del passaggio dal tradizionale al prefabbricato (in c.a. in quanto il ferro era decisamente più costoso in Italia, al contrario dell’Inghilterra e di gran parte del mondo). Passaggio che richiede un cambio di metodologia progettuale, dove non sono più possibili varianti in corso d’opera delle strutture e dell’involucro, e che comporta un percorso di progettazione il quale inizia, come qualsiasi progetto, dall’ideazione attraverso schizzi e disegni preliminari - che però già contengono la concezione costruttiva (altro che decostruttivismo!) - cui segue l’elaborazione esecutiva architettonica, e poi il ‘progetto costruttivo’ (di competenza dell’azienda che realizza i prefabbricati, ma sempre seguito dall’architetto in tutto il suo sviluppo). Definiti gli abachi dei diversi componenti e i disegni di assemblaggio, vengono realizzati i casseri. Segue la produzione in stabilimento e poi in cantiere dove, tempo una settimana, due, per il montaggio, e appare l’intera struttura e l’intero involucro, praticamente anche con la finitura finale.
Negli anni 80-90, mentre ero preso dalla volontà di ‘materializzare’ qualcosa di quanto avevo appreso in Via dei Lucchesi, nell’insegnamento universitario veniva sostanzialmente vietata questa metodologia di progettazione. Un architetto del Comune di Roma, guardando il mio progetto di un asilo prefabbricato (poi realizzato) mi disse “a mia figlia che studia architettura i professori vietano di usare una qualsivoglia base modulare di costruzione del progetto, non so perché… ”. Perché per i critici ufficiali di quegli anni il c.a. doveva essere quel materiale che contrastava con gli altri materiali ‘lisci’ (metalli, vetri), quindi decisamente un faccia vista ‘rustico’, una questione meramente estetica (poi, come abbiamo visto, c’è stato chi lo ha voluto liscio ma gettato in opera). L’architettura doveva conformarsi al progetto visto dall’esterno (il contrario dell’architettura organica, la cui prima e forse unica regola, è sviluppare il progetto dall’interno verso l’esterno), quindi ampio utilizzo di renders il più possibile lontani da geometrie elementari, come se questo bastasse per definire un progetto complesso.
NECESSITÀ DI SISTEMI COSTRUTTIVI INDUSTRIALIZZATI
Pur nell’epoca dell’informatica, delle esplorazioni spaziali e dell’intelligenza artificiale, nell’edilizia corrente, a parte poche eccezioni in cui qualche parte della costruzione è industrializzata (ad esempio le facciate), per il resto, per quanto riguarda strutture e involucro, si continua a costruire come nell’antichità più il cemento armato in opera. Ma il sistema costruttivo tradizionale, al di fuori di interventi su edifici esistenti, è oramai insostenibile per i seguenti motivi.
In presenza di fenomeni globali che investono la sicurezza dei territori e delle aree urbanizzate quali inquinamento, cambiamenti climatici, deforestazione, desertificazione, alluvioni, tsunami e tenuto conto dell’esplosione demografica nei paesi in via di sviluppo, non si può non considerare la necessità di doversi attrezzare culturalmente e tecnicamente, allo scopo di costruire, velocemente e in qualità, quanto necessario per implementare e soprattutto rinnovare/ristrutturare l’esistente.
La diffusione della prefabbricazione e dell’industrializzazione si impongono per carenza di manodopera qualificata, per migliorare la sicurezza nel cantiere, per ridurre i consumi di materiale ottimizzandone le prestazioni, per la possibilità di dimezzare i tempi di esecuzione lavorando in parallelo, produttivamente “off-site” e assemblando “in-site”.
SUPER HIGH TECH E ARCHITETTURA SISTEMICA IN VERTICALE
Mentre la critica si occupava, come si occupa tuttora, della celebrazione della moda di turno (disconoscendo magari quella incensata fino a poco prima), fortunatamente c’è stato chi ha realizzato delle anteprime del costruire contemporaneo. Già negli anni 78-86, Rogers, nei Lloyd’s di Londra, aveva realizzato un atrio, alto 60 metri su un’altezza complessiva della costruzione di 88 metri, illuminato naturalmente attraverso una copertura in vetro. Modulare in pianta, ogni piano può essere modificato aggiungendo o rimuovendo tramezzi e pareti. Tra le tante innovazioni tecnologiche e strutturali anche dei super-pilastri (per resistenza e sistema di assemblaggio), migliori delle colonne di grandi dimensioni già note. Quanti critici se ne sono accorti?. E negli anni 79-85 Foster, nella sede centrale della HSBC-Hong Kong and Shanghai Banking Corporation alta 180 metri, attraverso l’impiego delle tecnologie più avanzate, aveva offerto una dimostrazione tangibile del risultato costruttivo e spaziale dell’applicazione di alcuni principi inderogabili dell’architettura moderna e contemporanea, ovvero:
- cercare un’integrazione con la città;
- ottenere, nel tempo, il massimo di flessibilità funzionale degli spazi interni;
- moltiplicare la varietà degli spazi;
- privilegiare la luce naturale;
- prefabbricare i componenti costruttivi ed ottimizzare i tempi di esecuzione.
Integrazione con la città. Il piano terra e il primo piano del grattacielo della HSBC sono adibiti a piazza pubblica coperta, l’atrio della banca è ai livelli superiori.
Massimo di flessibilità funzionale degli spazi interni. Il raggiungimento di questo obiettivo passa per due fondamenti dell’architettura moderna e contemporanea: ottimizzazione delle strutture e modularità del progetto. Questi due fondamenti, che i cosiddetti decostruttivisti hanno voluto abolire…( quanto è più facile esercitarsi in plastici senza vincoli funzionali e strutturali!), in questo progetto raggiungono una evidenza massima. A questo scopo Foster adotta una struttura in acciaio costituita da otto piloni a traliccio, ciascuno costituito da quattro tubi collegati tra loro, che portano cinque travi reticolari metalliche, dell’altezza di due piani ciascuna, che sorreggono, appesi, cinque volumi ciascuno costituito da solai in numero variabile da 5 a 8. A parte i vincoli costituiti dalle strutture portanti primarie - peraltro ridotti al minimo anche perché i solai sono appesi a tiranti metallici molto esili - tutto può essere modificato in futuro. Le scale mobili, gli ascensori e i moduli prefabbricati dei servizi potranno essere sostituiti o spostati. Gli stessi solai potranno essere soppressi o modificati. Anche una futura diversa suddivisione degli uffici non necessiterà altro che di parziali smontaggi e rimontaggi di pareti divisorie.
Moltiplicare la varietà degli spazi. Interi piani adibiti ad uffici aperti (sempre con affaccio verso i vuoti interni e verso l’esterno), terrazze in corrispondenza dei due piani che contengono le strutture primarie trasversali, il grande vuoto dell’atrio principale alto 52 metri, tutto concorre a questa varietà spaziale. L’interno nel suo complesso: una vera “passeggiata nello spazio”.
Privilegiare la luce naturale. Al contrario della maggioranza dei grattacieli, la HKSB è studiata per permettere la diffusione della luce naturale quasi ovunque. Le sezioni generali, longitudinale e trasversale, mostrano doppie altezze e vuoti interni che, abbinati alle grandi vetrate, fanno comprendere come la luce naturale raggiunga la maggior parte degli uffici. Un sistema di specchi, posto al livello superiore del grande atrio, riflette i raggi solari nella grande hall.
Prefabbricare i componenti costruttivi ed ottimizzare i tempi di esecuzione. A parte le fondazioni, la costruzione in sito è consistita, essenzialmente, nell’assemblaggio di componenti prefabbricati provenienti, a volte, anche da paesi molto distanti come Gran Bretagna, Germania e USA.
In questa costruzione è evidente che il costo non è stato certo l’unico elemento considerato per la scelta di materiali e fornitori. Siamo in presenza di un’opera super high tech che per livelli di precisione e controllo è prossima alle procedure praticate per le costruzioni di impianti nucleari o nell’aeronautica; ma le basi metodologico-progettuali e costruttive sono le stesse anche in piccole costruzioni prefabbricate. Quello che serve, alla piccola come alla grande scala, è una formazione culturale adeguata che consenta all’architetto un approccio costruttivo attraverso componenti anziché attraverso la messa in opera di mattoni, calce, strutture gettate in opera. Formazione quindi in direzione di un’architettura sistemica, proprio quella pressoché negata nelle università, dove prevale l’emulazione di modelli formali fini a se stessi, ristretti all’ambito volubile delle mode. Al contrario di quanto si studiava fino agli anni ’70, ovvero i progetti di valenza architettonica e costruttiva non effimera ma epocale.
Pur in scala minore, questo progetto indica le basi progettuali per arrivare a costruire, ad esempio, un’Arcologia tipo quella disegnata da Soleri per Tokio nell’ambito di una ricerca promossa, nel 1994, da più corporazioni e dallo stesso governo giapponese alla ricerca di soluzioni per la città del XXI secolo. Ma la distanza tra il realizzato ad Hong Kong e il proposto a Tokio è nelle attività contenute. Finché saranno solo uffici non esisterà ancora il rinnovamento urbanistico che serve se non nell’attacco a terra. Nella torre alta 1.000 metri di Soleri le attività sono anche residenziali, commerciali, culturali, collettive. Un’intera parte di città si trasferisce in altezza per realizzare il verde al posto di un quartiere che si estende, estremamente piatto, per 360 ha.
CITTA’ SISTEMICA IN ORIZZONTALE CON EMERGENZE
Esiste un altro campo di ricerca verso la città sostenibile oltre alla città sistemica in verticale, è la città sistemica in orizzontale con emergenze; non più costituita da strade, marciapiedi, aiuole, piani terra commerciali, palazzine residenziali e centri commerciali (spesso da essa avulsi), bensì concepita per componenti urbanistici.
Vi sono dei principi base da considerare per un effettivo rinnovamento urbano delle città e per la definizione di modelli abitativi innovativi sostenibili e, in quanto tali, contemporanei. Ma qui entra in gioco il libro dell’amico architetto Michele Leonardi che ha spiegato al meglio di cosa si tratti nel suo libro “Verso un altro habitat” volume I capitolo 3. Col suo permesso accordatomi (Michele mi ha ringraziato vivamente per la pubblicità che gliene deriva, nonché per la mia onestà intellettuale, a differenza di chi nemmeno si perita di citare la fonte di loro presunte argomentazioni originali), ne sintetizzo e cito (in corsivo) alcuni passi fondamentali.
La scala della struttura portante. “Se prendiamo la struttura di un viadotto autostradale o di un ponte, con i suoi piloni e le sue grandi campate, e la paragoniamo allo scheletro di cemento armato di un qualsiasi edificio residenziale in costruzione, di cosa ci accorgiamo? Di una differenza totale nel loro modo di misurare lo spazio.”
Sollevamento delle masse e relative funzioni dal livello del suolo grazie alle nuove possibilità offerte dalle tecniche costruttive moderne. Così il suolo viene liberato e può avere valenza sociale e funzionale.
Separazione dei percorsi, non solo sul piano, nelle 2 dimensioni, ma anche tridimensionalmente. Questo si ricollega all'architettura "sollevata da terra".
Tra gli esempi di separazione dei percorsi della viabilità "meccanizzata" e pedonale, il primo esempio notevole è quello di Villa Adriana a Tivoli, la cittadella dell'imperatore romano Adriano, in cui le strade che permettevano il trasporto delle merci e il passaggio degli uomini a cavallo erano nettamente separate, essendo sotterranee, dai percorsi totalmente pedonali dei viali, dei colonnati, dei portici, e di tutte le funzioni residenziali, di rappresentanza, delle terme e culturali della stessa cittadella imperiale. Sempre sotterranei erano anche altri percorsi dei servizi necessari al funzionamento di questo polo multifunzionale territoriale.
Un altro esempio si ritrova nei disegni di Leonardo da Vinci di studio di una città ideale, in cui tutte le strade percorse da carri erano ad un livello più basso rispetto ai percorsi pedonali fiancheggianti i palazzi: una sorta di Venezia senz'acqua nei canali, con ponti per passare da un palazzo all'altro. Una qualsiasi rete metropolitana moderna costituisce un ulteriore esempio di separazione dei percorsi; così pure una monorotaia sede di mobilità meccanizzata sollevata da terra. In generale, la gamma di possibilità funzionali e architettoniche offerta dalla separazione dei percorsi, sia a livello urbanistico che di organismo edilizio, è notevole. Specialmente se si pensa in termini tridimensionali e non bidimensionali.
Riduzione dell’eccesso di mobilità attraverso la concentrazione di funzioni, altrimenti disperse nel territorio, in ‘poli urbani e territoriali’ che vedrebbero raggruppati servizi pubblici, spazi del terziario e del direzionale. Si avrebbe così un sistema ben strutturato di centri nevralgici, realizzabile in più fasi, nel tempo, come tanti tasselli ad incastro. In questo modo, nell’ambito della ristrutturazione delle città, si attuerebbe la realizzazione di nuove centralità urbane, dando al contempo fisionomia a tanti anonimi sobborghi urbani.
La pratica urbanistica dello zoning, quando non l'assenza totale di pianificazione, hanno fatto sì che la gente si muova freneticamente da un capo all’altro della città per fare più o meno due, tre semplici cose. In simili centri il cittadino potrebbe parlare con un funzionario pubblico, passare in banca, spedire un documento materiale, fare una visita in uno studio medico-specialistico, recarsi in banca, senza dovere necessariamente percorrere chilometri in macchina o a piedi, con tutto il conseguente tempo dovuto per tali spostamenti. Poter fare anche solo due di tutte queste cose nello stesso luogo comporterebbe un notevole risparmio di energie individuali e non solo.
Polifunzionalità per un luogo vitale. La scelta dell’accostamento di vari gruppi di funzioni permette di avere un centro potenzialmente attivo a tutte le ore del giorno e tutti i giorni dell’anno, evitando che ad una certa ora del giorno un ‘Polo territoriale’ si trasformi in una “terra di nessuno”, così come accade nei quartieri direzionali moderni. La pluri-funzionalità fa sì che il decadimento o la stagnazione di un gruppo di attività non comporti il decadimento di tutto il Neo-centro. Un’altra prerogativa dell’accostamento di gruppi di funzioni diverse (per esempio direzionali, terziarie, residenziali, commerciali, del tempo libero, culturali, ecc.) è quella di favorire gli incontri fra le persone rivitalizzando determinate funzioni urbane utili alla coesione sociale, altrimenti disperse nella città e sottoutilizzate o confinate in modo promiscuo negli edifici residenziali.
Interscambio modale. Attestare i Poli urbani e territoriali in corrispondenza dei Nodi del traffico di linee ferrate e veicolari, quali le stazioni ferroviarie, le stazioni della metropolitana, i parcheggi di scambio o in prossimità delle autostrade e tangenzialmente a queste. L’ideale è che questi Poli si attestino nei punti di intersezione di entrambi i due sistemi di trasporto, e viceversa. Il beneficio in termini di traffico sarebbe evidente: un treno lungo 7 vagoni passeggeri trasporta 300 passeggeri, altrettante persone in automobile formerebbero una fila lunga 1,5-2 km., con tutta la conseguente congestione veicolare.
Viabilità meccanizzata "leggera" per spostamenti rapidi meccanizzati - alla scala locale dei centri nevralgici - mediante monorotaie (già realizzate a Seattle, Miami, Lille, nonché in altre città e aeroporti del mondo).
Dai Poli urbani le linee di ‘people mover’ lasciano libera la scena urbana, a meno degli esili piloni di sostegno, lungo il tragitto, per ‘vincolarsi’ alla scena urbana in corrispondenza delle fermate. Lì si possono attestare alcuni servizi collettivi. A differenza delle linee metropolitane hanno costi molto più contenuti e si realizzano in breve tempo. Di contro, non possono spostare un flusso di persone dello stesso ordine di grandezza di quello delle linee metropolitane o delle ferrovie. A differenza delle linee tranviarie non occupano la superficie urbana e non costituiscono un nuovo margine urbano, una nuova barriera.
Sistematicità del costruire: componenti, vettori, prefabbricazione. Per costruire nuovi Habitat dobbiamo essere sistemici. I nostri componenti devono spaziare dal sistema costruttivo a quello delle cellule abitative prefabbricate, fino alla dimensione urbana e territoriale attraverso l’uso di pochi semplici strumenti, che definiamo, secondo il dato contingente, con grande attenzione alle relazioni che stabiliamo tra essi.
Anche con pochi elementi o componenti a disposizione si deve saper realizzare la complessità. Mettiamo di dover costruire tre muri l’uno in prossimità dell’altro. Disposti in un dato modo sono, non solo tre muri, ma anche una corte chiusa all’interno di essi. Passando ad un livello di complessità di poco maggiore, alcune tipologie “ad elle”, in base alla loro disposizione, possono creare spazi a verde, pedonali, ecc., significativi e mai uguali l’uno all’altro.
Altro esempio: integrare un centro commerciale con parcheggio ad edifici residenziali e spazi direzionali, liberando, in tutto o in parte, terreno a terra per creare un’isola pedonale, porta ad ottenere qualcosa che è molto di più della semplice somma di tutte queste funzioni; lo spazio a terra liberato si può anche usare per manifestazioni, mercato settimanale all’aperto, e tante altre cose ancora. Purtroppo in tutto il mondo si tende sempre più a realizzare scatole e contenitori chiusi e a sé stanti: megacentri commerciali, poi un isolato più in là un cinema multisala, un po’ più in là una biblioteca, un teatro. Sempre per settori e aree funzionali distinte, insomma sempre per zoning, cioè sempre a zone omogenee urbanistiche, piatte. E ciò accade nel migliori dei casi, perché altrimenti troviamo una stazione qui, e un chilometro più in là un palazzo dello sport, poi a tre chilometri di distanza un centro commerciale.
Senza capacità di progettazione urbanistica, il costruito per gli umani diventa simile ai container accatastati nei porti o ai tristi casermoni residenziali di tutte le periferie del mondo privi di organizzazione spaziale e funzionale, banalmente ‘accumulati’.
L’appiattimento culturale mondiale e il conformismo fanno sì che questo modo di abitare la Terra appaia come un destino ineluttabile per l’uomo contemporaneo e del futuro.
Integrazione a tutti i livelli. Relazioni tra le parti dell’organismo architettonico progettato e relazioni di questo con il contesto. Il progetto va visto sempre ad una scala spaziale e temporale più ampia dell’ambito di intervento (apparentemente) strettamente necessario. Bisogna pensare in termini di processi che generano processi nel corso del tempo e ad una distanza e scala maggiore di quella del luogo del progetto.
Prefabbricazione dei componenti edilizi e dei sistemi architettonici. La produzione controllata in officina di un determinato bene permette di ottenere delle economie di scala su determinate quantità del medesimo bene prodotto. Inoltre un tale processo “controllato” in officina, con un impiego X di manodopera qualificata e non, e un impiego Y di macchinari appositi, permette di raggiungere degli standard qualitativi altrimenti irraggiungibili in cantiere.
La prefabbricazione è utile non solo quando permette di realizzare delle economie all’interno del singolo processo edilizio, ma è ancor più utile quando permette la creazione di un linguaggio architettonico che caratterizzi quell’edificio.
Per fare un esempio, Luigi Pellegrin aveva ideato degli alloggi di emergenza prefabbricati in officina molto più economici di quelli che siamo soliti vedere dopo l’ennesimo terremoto in Italia o altrove. Alloggi di emergenza, la cui peculiarità era però avere subito la qualità e vivibilità del costruito. Non si trattava di “pezzi di edilizia”, container o pseudo-cottage stesi su un campo, bensì di componenti il cui assemblaggio poteva generare un villaggio, una comunità, un nuovo nucleo insediativo degno di questo nome, non un accampamento disumanizzante, umiliante, e soprattutto inutile.
Le idee e i criteri esposti non sono affatto delle norme metodologiche universali. Invece la logica ad esse sottese è un esempio di “metodo”. Questo metodo può essere opinabile o perfezionabile, ma c’è.
COME E DOVE APPLICARE L’URBANISTICA SISTEMICA
Sarebbe quanto mai utile concentrare le potenzialità dell’architettura sistemica in funzione di una possibile metamorfosi delle periferie. Basterebbe raggiungere qualche primo risultato, anche parziale, per indicare (e convincere) che ci sono soluzioni per attrezzare e rendere più sostenibili i luoghi dove oggi vive la maggioranza della popolazione mondiale. Certo si inizierebbe dalle periferie del mondo sviluppato, per ovvie maggiori capacità di investimento che inizialmente solo in quelle parti del pianeta possono trovarsi. In tempi successivi però, alle prime soluzioni, potrebbero seguire giusti sviluppi anche in grandi città di paesi in buona parte già sviluppati, come ad esempio Bogotà. Dove invece oggi c’è solo l’accumulo di abitazioni-barattolo, tende o quant’altro possibile con gli scarti urbani, bisognerebbe costruire quartieri nuovi di sana pianta. Anche in questi casi si dovrebbe attingere all’architettura sistemica, rinvenibile, ad esempio, in molti progetti di Pellegrin per l’Africa. Mentre per ridurre consumi energetici ed inquinamento è prioritario intervenire sulle periferie, in tutto il mondo, attraverso la metodologia dell’architettura sistemica.
ARCHITETTURA SISTEMICA ALLA PICCOLA SCALA
Non si pensi che l’architettura sistemica si possa applicare solo alla grande o media scala. Ad esempio Johrn Utzon, quando andò ad abitare a Maiorca, si costruì la sua casa in un modo che potesse permettere successive “addizioni” e secondo una modalità costruttiva sistemica creata per l’occasione utilizzando materiali del posto. Un’architettura aliena da forme compiute a priori, dinamica, ampliabile, facilmente trasformabile; dove i componenti costruttivi a faccia vista, pur nella loro semplicità estrema, offrono una vasta sequenza di varianti costruttive e spaziali. I volumi risultano concatenati mediante patii e portici in una continua alternanza di pieni e vuoti. I passaggi tra un volume e l’altro sono sempre diversi, mai “assiali”, sempre luminosi. Negli interni, alla luce diffusa si aggiungono raggi di luce prodotti da studiate feritoie. Nel complesso una lezione, utilizzando i materiali del posto ma non le sue tipologie. In questo senso Casa Lis ne è una nuova che va ad aggiungersi a quelle tradizionali esistenti, introitando un passato non necessariamente e non del tutto locale. Organica alla maniera delle ultime ville californiane di Frank Lloid Wrigth. La materia povera del posto – principalmente arenaria “Mares” - è esposta ai venti che la modificheranno col tempo. Architravi e solai sono realizzati impiegando piccoli travetti prefabbricati in c.a. su cui, nel secondo caso, poggiano delle voltine. Spesso l’arredo è fisso, perfettamente integrato e in parte impreziosito da ceramiche locali. Utzon stesso commento’: “un principio puro di addizione implica una nuova espressione, implica una nuova forma architettonica, una nuova espressione, con le stesse caratteristiche e gli stessi effetti che si ottengono, per esempio, aggiungendo alberi ad un bosco o pietre ad una spiaggia…questo gioco risponde alle domande della nostra epoca”. E’ un esempio dove è facilmente leggibile il “sistema” pur nella massa materica omogena. Si tratta essenzialmente di colonne in pietra poste a distanza modulare tra loro che determinano la griglia strutturale all’interno della quale si sviluppano piccoli portici o, tamponati sempre con blocchi di pietra, i volumi degli ambienti chiusi. Dimostrazione di come con pochi componenti si possa creare un’infinità di spazi e variazioni. Lo stesso Utzon che negli anni precedenti (’50-’60) aveva ideato e realizzato il prototipo dell’architettura Higth Tech, l’Opera di Sidney - con l’ingegnerizzazione, come si direbbe oggi, dello studio Ove Arup (già attivo ed affermato allora) e la costruzione affidata alla australiana Permasteel, successivamente unita alla Isa di Vittorio Veneto a formare la Permasteelisa – si, proprio il pioniere dell’ Higth tech dei nostri giorni, a Mallorca ha dimostrato che anche con una tecnologia povera, anzi poverissima, si può fare ottima architettura. Passando nella vicina Ibiza, ancora si può trovare qualche esempio di architettura ibizenca originale, che non ha nulla a che vedere con le case impropriamente definite “ibizenche” in riviste di moda solo perché bianche. Si tratta invece di case in territorio agricolo per le famiglie degli agricoltori concepite come composizione, aperta a successivi ampliamenti, di volumi modulari pressocchè cubici (vedi il testo “Bioclimatica, storia, tecnica, architettura” di P. Cascella). Che dire dell’architettura domestica giapponese, assolutamente modulare e sistemica, tutta misurata secondo il tappeto-stuoia che usavano per “vivere” sul pavimento. Non c’è migliore descrizione di quella che fece F.L. Wrigth: “ ……………….. “ (vedi il testo “Bioclimatica, storia, tecnica, architettura” di P. Cascella).
CONTINUA ...