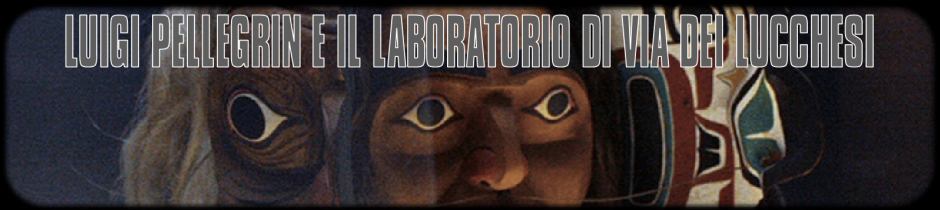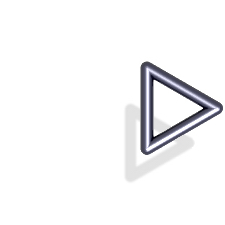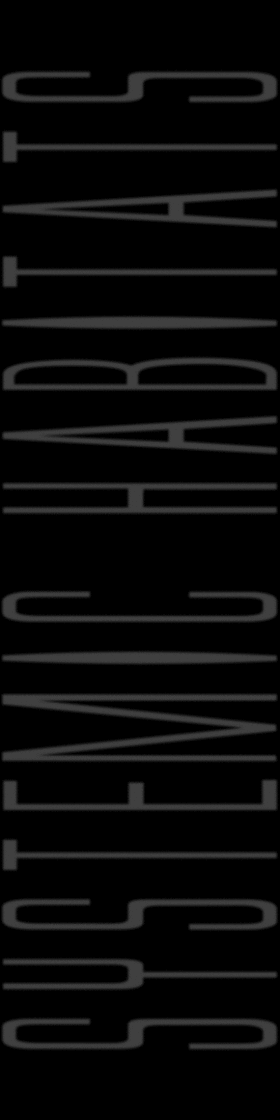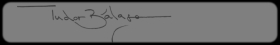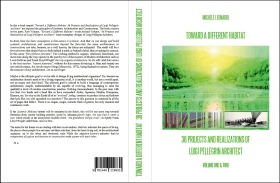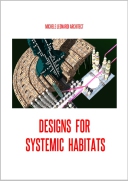Capitolo 1 - Testimonianze
LUIGI (GIGI) PELLEGRIN: UNA VITA CONFUSA CON L'ARCHITETTURA
di Bruno Nicola Rapisarda © - 26 novembre 2012
L’INCONTRO CON L’ARCHITETTO
La prima volta che lo vidi trovai che Lui, anche nell’aspetto, corrispondeva alla figura leggendaria del Maestro che ogni studente d’architettura un tempo aveva: capelli bianchi, occhi azzurri, alto e magro come un’asceta d’appena 43 anni. Dell’asceta possedeva anche la frugalità (mangiava solo la pagnotta imbottita con bistecca che gli portavamo noi al ritorno dalla trattoria all’angolo verso Fontana di Trevi e dormiva solo tre ore a notte, a studio, steso su un divano): pensare che possedeva sull’Aurelia la spaziosa villa wrightiana, da lui stesso progettata, che conosciamo. I rapporti con la moglie (che vidi passare da studio solo qualche volta) probabilmente s’erano esauriti perché non aveva tempo per alimentarli. La consueta giornata di lavoro per lui era: sveglia alle nove, colazione, poi iniziava il lavoro che proseguiva anche durante la nostra pausa pranzo. Dopo la pagnotta con bistecca riprendeva l’attività che spesso si concludeva all’alba, nel suo studio privato, dopo una conversazione notturna a tutto campo sull’architettura in generale e sulle opere che in quel periodo avevamo in fase di progettazione. Alla discussione partecipavano tutti i presenti (anch’io ch’ero l’ultimo arrivato e frequentavo appena il II anno d’università).
In quel periodo l’Architetto era stato incaricato di progettare una fabbrica nei pressi dell’autostrada e fu quello il tema trattato in una delle nostre riunioni notturne: si cercava di capire come ci si dovesse porre di fronte a quella particolare “tipologia architettonica”. Si sviscerarono come sempre i vari elementi di cui si sarebbe dovuto sostanziare il progetto: il diverso “peso” che avrebbero assunto. Ciascuno disse la sua ma fu Pellegrin stesso a far emergere quale sarebbe stata, in quel caso, la componente dominante del progetto: la sua particolare posizione vicino all’autostrada che obbligava quell’architettura a rappresentarsi come forma simbolica riconoscibile per diventare una sorta di cartellone pubblicitario. Io, che credevo nell’architettura come spazio fruito, ebbi difficoltà ad accogliere quella soluzione che faceva prevalere l’involucro ma compresi che, eccezionalmente, stavolta questa sarebbe stata la scelta opportuna. In ogni caso ero certo che quell’involucro non avrebbe contenuto occasionali vuoti anonimi del tutto incongrui con le necessità funzionali dell’opera (come accade invece per le stupefacenti volumetrie degli architetti “neofacciatisti” che inquinano oggi il panorama delle “moderne” città e ammorbano con foto di ridondanti esterni le insidiose pagine delle riviste specializzate). Un altro esempio illuminante della rarefazione dei temi trattati lo ebbi la volta in cui, si parlò d’un certo edificio, impiantato ad arco di cerchio, progettato lateralmente ad una strada rettilinea a scorrimento veloce. La notte trascorse ragionando sulle nefaste conseguenze che avrebbe potuto comportare per l’automobilista di passaggio l’arco d’ombra proiettato dall’edificio sulla strada. Era la notte di Capodanno ma nessuno fece cenno all’Evento.
Diceva spesso “non facciamo poesia” volendo affermare la necessità d’interpretare l’architettura utilizzando un linguaggio razionale ch’e logos (pensiero, riflessione, enumerazione), pur essendo consapevole che, per formulare l’Architettura quale sistema complesso (ch’è l’insieme di elementi combinati che producono risultati inediti: diversamente dalla somma delle parti), bisognasse usare l’intuizione lirica, il linguaggio poetico: l’eidos.
Ricordo quanta poca considerazione avesse per ciò che si poteva apprendere in Facoltà. Secondo lui l’architettura andava praticata coinvolgendosi interamente, e nel suo studio quell’esercizio si sovrapponeva all’esistenza stessa, non v’era spazio per altro: il resto era solo un’insignificante perdita di tempo, una sorta di non vita, un imperdonabile spreco. Quella sua percezione trascendente avrebbe potuto perdermi: si, perché non potevi frequentare per molto tempo il Maestro senza subirne il fascino, essere catechizzato, officiare il culto dell’Architetto Demiurgo ordinatore del mondo. Così sarebbero arrivate, in progressione inesorabile, l’epifania, l’agnizione, l’assimilazione: che altro ci stavi a fare al mondo se non per trasformare il Caos in Cosmo.
Ricordo le poche volte che cercai d’esporgli le mie necessità d’avere tempo da dedicare allo studio per sostenere gli esami: mi fissava coi suoi occhi azzurri come stesse guardando un ufo. Il suo era uno sguardo sorpreso, incredulo, dal quale traspariva una certa commiserazione. Rispondeva invariabilmente che “quello” era il luogo dove si professava l’architettura.
In una particolare occasione osai parlargli d’un impegno mondano che mi avrebbe costretto ad uscire da studio prima del previsto. Mi rispose: “Ma dove vai? Questo è il tuo solo impegno: hai la fortuna e l’opportunità di fare il mestiere più bello del mondo e vai cercando altro”.
Quel viatico m’inquietò per decenni, infine, compresi che l’Architettura era solo un Mito: lo stupefacente Artificio con cui l’uomo configura l’ordine simbolico del Mondo nel tentativo illusorio di renderlo stabile per dare simbolico senso alla propria esistenza, per non smarrirsi, invece di ricercare le leggi che presiedono da sempre l’indefinito divenire dell’Universo volendo sperimentare le modalità che potrebbero consentirgli d’anticiparle per governarne intenzionalmente l’ineludibile processo.
Assieme all’Architettura, Pellegrin, coltivava il Mito di Wright: nella sala dei collaboratori campeggiava la foto del Maestro americano e la sua voce risuonava da un giradischi che veniva acceso appositamente per far girare l’ellepì con le sue “conversazioni” tutte le volte che lui sentiva il bisogno di quell’ispirazione. In alcune occasioni mi capitò di sentirlo dialogare al telefono con Bruno Zevi, entrambi adoratori dello stesso culto (l’Architettura Organica) e del suo “Unico-Vero-Dio” (F. L. Wright), la cosa quindi non mi stupì. Sebbene, in quel periodo, Pellegrin stesse partecipando ad un “concorso d’idee” di cui Zevi era il presidente di commissione: escludo che vi fosse tra loro qualche meschina intesa economica ma quel loro ideale comune li rendeva, ai miei occhi ingenui, oggettivamente “complici”.
Tra le cose che mi passarono per le mani ricordo il progetto d’una delle tante scuole prefabbricate di cui l’Architetto era stato incaricato. Ricordo quella maglia quadrata che imponeva rigidi limiti d’impianto e la capacità del Maestro d’adattarla funzionalmente alla sua sensibilità “organica”.
Pellegrin credeva fermamente nella necessità di modernizzare il processo produttivo dell’architettura utilizzando tecnologie che la svincolassero dai tradizionali modi di costruire “in opera” (nonostante la sua libertà compositiva sembrasse cozzare con quell’assunto). Da qui il suo ossequio all’industrializzazione edilizia e, quindi, alla prefabbricazione che lo aveva indotto, in quel periodo, a ritenere necessario costruirsi una maglia di base tutte le volte che iniziava qualsiasi progetto, fosse o meno da realizzare con moduli prefabbricati. Quella sua ricerca si radicava, nella lezione del Bauhaus, quindi di W. Gropius e dell’International Style: questi ultimi apertamente detestati dal Maestro e dal suo Mentore.
Uno dei visitatori più assidui dello studio era il Prof. Ciro Cicconcelli, da sempre suo amico, consigliere e procacciatore di lavori. Difatti, vedi a volte le coincidenze, Pellegrin, già “anziano”, fu nominato professore alla Facoltà d’Architettura proprio all’epoca in cui “Ciro” ne era il Preside. Certo, Pellegrin meritava più di chiunque altro quell’incarico ma sappiamo che questa non e’ una nazione che valorizza i meritevoli.
(segue)